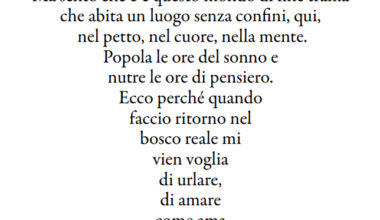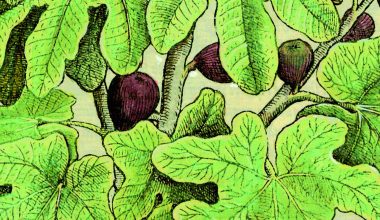Per vincere la soggezione verso la natura, un “ragazzo di città” può imparare a contemplarla attraverso l’arte. E imparare così a dare un nome e un senso alle piante. Qual è dunque l’enigma al centro del romanzo di Alessandro Zaccuri?

Quello del Dono di Humboldt è uno dei più bei finali di romanzo che conosca, forse perché il libro l’ho letto quand’ero davvero molto giovane. Attorno al 1978, credo, un paio di anni dopo l’assegnazione del Nobel a Saul Bellow.
Il poeta Humboldt muore, il suo allievo Charlie Citrine partecipa al funerale e, sulla via del ritorno, scambia qualche parola con l’amico Menasha Klinger, il quale si accorge che tutt’intorno, nelle aiuole del cimitero, stanno spuntando piccoli fiori che probabilmente annunciano la primavera. «Eccone un altro, là – dice Menasha – Come credi che si chiamino, di’, Charlie?». La risposta è memorabile: «E che ne so? Sono un ragazzo di città, io. Saranno crochi».
La soggezione nei confronti del mondo vegetale, l’ostinazione nel voler pronunciare un nome, non importa se sbagliato. Su tutto, l’ammissione di essere “un ragazzo di città”, che magari vive in una metropoli piena di alberi, parchi e giardini (Il dono di Humboldt è ambientato tra Chicago e New York), ma che a quella foresta urbana, per un motivo o per l’altro, non ha mai prestato attenzione.
Il finale mi è rimasto impresso perché, pur accusandomi, in parte mi scagionava. “Saranno crochi” mi sembrava comunque un tentativo rispettabile, indipendentemente dal risultato. A ripensarci, l’azzardo botanico è una delle azioni più nobili e generose che Charlie compia nell’intera vicenda di cui è protagonista e narratore.

Scopri il libro su ABOCA EDIZIONI
Per quanto mi riguarda, sono dovuto andare molto lontano per trovare i miei crochi o, meglio, il mio albero. Nel 2014, durante un viaggio di pochi giorni a Buenos Aires, mi è capitato di visitare la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, un bel museo che si affaccia sullo scenario fin troppo sofisticato del canale di Puerto Madero. Lì, oltre ai dipinti in stile gauchesco e ai capolavori dell’informale argentino, è custodito un nucleo di opere europee, nel quale figura una delle numerose versioni che Pieter Bruegel il Giovane trasse dal Censimento di Betlemme realizzato dal padre, Bruegel il Vecchio, nel 1566. Era un quadro che non conoscevo o sul quale forse non mi ero mai soffermato, come Charlie con i crochi. Mi colpiva che, in posizione arretrata e non esattamente centrale, ci fosse un albero morto, all’interno del quale la brava gente di Betlemme aveva allestito una specie di bettola.
Quel frassino, perché di un frassino si tratta, è stato l’inizio del mio personale viaggio attraverso l’opera del Vecchio, per usare l’appellativo al quale ricorre il narratore della Quercia di Bruegel. Il quale, a differenza di quanto accade nel Dono di Humboldt, è solo testimone, e non protagonista della storia che lentamente, nel corso di questi ultimi anni, si è sedimentata a partire dalla curiosità suscitata in me dall’incongrua presenza di un Bruegel sulle sponde, o quasi, del Río de la Plata.
Anch’io, come il mio narratore, sono andato a Bruxelles, esattamente un anno prima degli attentati ricordati nel racconto. Ho letto gli stessi libri che lui dichiara di aver letto, spesso apprezzandoli più di quanto lui dichiari di averli apprezzati. E come Matilde, la donna che della Quercia di Bruegel è la vera protagonista, sono stato a Winterthur, non lontano da Zurigo, per ammirare L’Adorazione dei Magi nella neve. Per una serie di ragioni che non occorre spiegare, anche il mio sguardo – come quello di Massimo, il marito di Matilde – è stato catturato da un dettaglio minore, addirittura minimo, che è poi diventato il motore del racconto. La trasferta in Svizzera, per inciso, è veramente avvenuta poco prima che la pandemia travolgesse l’Europa, finendo così per assumere un valore in qualche misura simbolico o, se si preferisce, di premonizione.
La quercia di Bruegel è una storia di spazi chiusi, non soltanto perché è stata scritta a ridosso della grande clausura del mondo, ma anche e principalmente perché è negli spazi chiusi che noi ragazzi di città, sempre condannati al paradosso, prendiamo finalmente coraggio e proviamo a dare un nome ai fiori, agli alberi, alle piante. Abbiamo bisogno di uno specchio che ci permetta di contemplare la natura attraverso un gioco di rifrazioni e non è raro che l’arte diventi per noi quello specchio: un modo per misurarci con la realtà senza che la realtà arrivi a disorientarci. L’immagine dello specchio, inoltre, mi pare si adatti bene alla tecnica narrativa impiegata nel libro, che è un omaggio dichiarato al congegno brevettato da Joseph Conrad e studiato da Henry James, che un po’ glielo invidiava. Il narratore raccoglie le informazioni che altri gli trasmettono per passarle a sua volta al lettore, “come secchi d’acqua per l’estinzione improvvisata di un incendio”, secondo la meravigliosa formula escogitata da James. Ora che ci penso, Pieter il Giovane, detto Bruegel degli Inferni, amava molto dipingere incendi. A lui devo il mio primo albero, il frassino che mi ha portato a indagare il segreto della quercia.